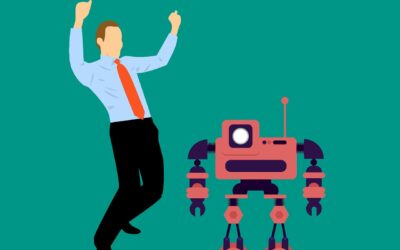È noto che la Regina Elisabetta, in occasione di una sua visita alla London School of Economics svoltasi a due soli mesi di distanza dal fallimento della società finanziaria Lehman Brothers, abbia rotto la consuetudine che voleva il monarca limitarsi a poche parole di circostanza, rimproverando i componenti dell’augusto consesso per non aver previsto la tempesta che proprio in quel frangente si stava addensando sulle economie e sulle società occidentali. Gli economisti della LSE si limitarono a balbettare poche imbarazzate risposte, ma il rimprovero di Elisabetta II era forse mal riposto: alla luce del dogma neoliberale di cui molti di essi erano imbevuti, una risposta convincente non era nell’orizzonte delle loro capacità. Al di fuori del dogma, una spiegazione era però possibile: anche perché i meccanismi che avevano condotto alla crisi non erano in funzione da pochi mesi o anni, ma operavano indisturbati da circa mezzo secolo.
Gli Stati Uniti erano stati tra i paesi più colpiti dalla Grande Depressione degli anni Trenta – se non il più colpito (non a caso l’evento scatenante fu il crollo di Wall Street del 1929). Tuttavia, grazie all’impianto riformatore del New Deal varato sotto la presidenza di Franklin Delano Roosevelt, e soprattutto in conseguenza dello scoppio della II Guerra Mondiale (con il suo portato di piena occupazione e di boom delle imprese belliche e del loro indotto), il gigante nordamericano era stato anche il primo ad uscirne. A guerra conclusa, negli USA le robuste spinte della politica e dell’opinione pubblica a rinchiudersi nell’isolazionismo prebellico erano state sconfitte dalla ravveduta necessità di dare proiezione globale alla superpotenza americana. Il crollo delle economie e delle società europee, assieme all’espansione della minaccia sovietica, bussavano alla porta della prosperità americana. Allo stesso tempo, grazie alle fortuite condizioni verificatesi negli anni della guerra, le grandi multinazionali e le banche internazionali con sede sul territorio statunitense disponevano di una ricchezza tale da spingerle ad espandersi a livello mondiale con investimenti diretti all’estero. Il mercato interno non era sufficiente ad assorbirne la produzione, per cui prendeva piede allo stesso tempo la necessità di incrementare le esportazioni; per questo c’era bisogno che anche in Europa la situazione economica migliorasse, affinché ai tedeschi, ai francesi, agli inglesi e agli italiani fosse possibile acquistare merci made in USA.
Ad integrare poi gli Stati Uniti nello scenario globale concorreva una spinta politica, dal momento che la possibilità dell’estensione della rivoluzione comunista minacciava il dispiegamento a livello mondiale delle potenzialità della libera impresa. C’era dunque un forte interesse a che gli alleati godessero di un successo economico sufficiente a garantire il benessere delle popolazioni e a distoglierle da propositi rivoluzionari. Questo complesso gioco di interessi rendeva necessaria una ripresa del dinamismo economico dell’area non soggetta all’espansione sovietica, in primo luogo l’Europa occidentale ed il Giappone. Queste aree iniziarono così ad avvantaggiarsi impetuosamente della protezione politica a stelle e strisce, dei capitali e delle tecnologie da lì importate, giovandosi allo stesso tempo di una manodopera a costo ribassato rispetto a quella statunitense. Con il risultato che col passare del tempo i prodotti di quest’area del globo raggiunsero una qualità pari a quella nordamericana, con il vantaggio commerciale di poter essere immessi sul mercato a prezzi inferiori.
Per il primo ventennio successivo al conflitto sembrò di aver trovato la quadratura del cerchio: “miracolo” economico in Europa e Giappone; sbocchi per gli investimenti e le merci americane; contenimento militare e sociale della minaccia comunista. Fu tra la fine degli anni Sessanta e la metà degli anni Settanta che su questo senario idilliaco si abbatté la tempesta perfetta. Sfruttando i vantaggi sopra descritti, i prodotti tedeschi, giapponesi, italiani ecc. si fecero troppo competitivi rispetto a quelli americani, penalizzando fortemente il made in USA. Al tempo stesso, le conquiste in termini di salari e di welfare del movimento dei lavoratori cominciarono ad esercitare una pressione insostenibile sui profitti, con conseguente scoppio dell’inflazione e crisi degli investimenti. L’avvenuta decolonizzazione non solo apriva nuovi margini di manovra all’URSS a livello globale, ma comprometteva ulteriormente le capacità di guadagno dei grandi gruppi industriali: l’aumento dei prezzi delle materie prime, per lo più allocate nel “Terzo Mondo”, si aggiungeva ai maggiori salari ottenuti dai sindacati occidentali e alla tassazione necessaria a mantenere alti i livelli delle prestazioni dello Stato sociale, diminuendo così ulteriormente i margini di profitto per le grandi corporations. Ciliegina (avvelenata) sulla torta, l’escalation in Vietnam colpiva sia l’economia statunitense per l’eccessivo deficit a cui la costringevano le esigenze del riarmo, sia la legittimità degli USA, impegnati in un’aggressione brutale ad un piccolo stato indipendente in lotta per la propria unità nazionale, a proporsi quali garanti del cosiddetto mondo libero.
Per tutti gli anni Settanta la situazione parve aperta agli esiti più imprevedibili, finché le classi dominanti non trovarono nell’ondata neoliberista lo strumento per arginate temporaneamente la propria crisi. Le avanguardie della restaurazione furono Ronald Reagan negli Stati Uniti e Margareth Tatcher nel Regno Unito, anche se le prove generali erano già state effettuate nel corso del decennio precedente, quando gli “esperti” della scuola di Chicago erano scesi al Sud del Rio Grande, chiamati ad applicare le proprie ricette neoliberiste in un ambiente reso propizio dalla sanguinarie dittature che sconvolgevano il Cono Sur sulle ali del Plan Condor.
Rimanendo nell’Occidente avanzato, se la grande fabbrica fordista era stato l’epicentro della prospettiva rivoluzionaria, una delle risposte fu proprio lo smantellamento dei luoghi privilegiati del conflitto, con l’avvio di ingenti processi di terziarizzazione, rivitalizzazione in chiave subordinata dalla piccola impresa, delocalizzazione e politiche favorevoli all’espandersi della rendita finanziaria. Si può dire che, proprio come il successo della strategia egemonica statunitense nel secondo dopoguerra ne aveva a lungo andare prodotto la crisi, così il successo della strategia del movimento operaio organizzato nella grande fabbrica integrata determinò la crisi di quella stessa strategia. Ma la dismissione degli investimenti dalla grande fabbrica fu solo una delle vie di fuga del capitale dalla tempesta perfetta che si era abbattuta su di esso. Un nuovo modo di accumulazione prese campo, un disegno globale di redistribuzione della ricchezza e del potere oligarchico che David Harvey ha chiamato “accumulazione per espropriazione”. Questa, più che una novità, rappresenta un’opzione di riproduzione del capitale sempre presente. Anzi, l’accumulazione per espropriazione, per Harvey, altro non è che il periodico tentativo da parte del capitale di ricreare le condizioni che tra il XVIII e il XIX secolo avevano reso possibile quella che Marx ha chiamato “accumulazione originaria”. Che tuttavia in Harvey perde questo carattere originario, proprio perché le sue caratteristiche sono destinate a riproporsi ciclicamente ogni qualvolta il capitale deve affrontare una crisi. Quelle stesse condizioni che hanno permesso l’accumulazione originaria, ad ogni fase di accumulazione per espropriazione sono destinate a espandersi orizzontalmente nel globo (dal Lancashire inglese teatro della prima rivoluzione industriale all’intero pianeta) e verticalmente per quanto riguarda la quantità di oggetti trasformati in merce: privatizzazione dei terreni, soppressione delle proprietà collettive e conseguente espulsione di manodopera dal “sud globale”, disposta a produrre merci e servizi ad un costo ribassato e con minori garanzie sociali rispetto a quella dei paesi sviluppati; avvio di una nuova tratta degli schiavi, da sfruttare nella campagne ma anche in altri mercati, come quello del sesso; generalizzazione del debito privato e uso politico del debito pubblico delle nazioni periferiche per piegare individui e popoli interi alle logiche dell’espropriazione.
Fu in questo contesto che furono smantellate le istituzioni politiche sorte a difesa della società in risposta alla devastante crisi degli anni Trenta, sostituite da organismi tecnocratici di cui era sbandierata l’imparzialità. Ogni paese o gruppo di paesi ha seguito una via particolare a questo processo di “sostituzione della politica per l’amministrazione”. Le prove generali risalgono alla metà degli anni Settanta, con la bancarotta della città di New York. Fu lì che le istituzioni tecnocratiche presero il potere per la prima volta. Su scala sempre maggiore, e con sempre maggiore frequenza, l’esperimento è stato ripetuto a partire dai primi anni Ottanta nei paesi del Terzo Mondo caduti sotto l’amministrazione controllata del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, in seguito alla sopravvenuta insolvenza del debito da essi contratto. Si è poi passati per l’abolizione della municipalità di Londra nell’Inghilterra tatcheriana, per giungere alla costruzione della Comunità europea come processo continentale di espropriazione della sovranità popolare – paesi come l’Italia avevano sviluppato istituzioni robuste di contrasto all’impiantazione della “società di mercato” che sono state smantellate col ricorso al “vincolo esterno” -; per giungere infine all’attualità dei trattati di libero commercio, con il loro seguito di tribunali “paritari” chiamati a giudicare quegli Stati che pongano ostacoli alle esigenze di profitto delle imprese trans-nazionali.
In questo panorama, la questione di quel fenomeno che abbiamo chiamato “uso politico del debito” acquista una particolare rilevanza. Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale nacquero, nell’ambito degli accordi di Bretton Woods del 1944, come organismi al servizio della stabilità della finanza e del commercio internazionale in età di embedded liberalism, di controllo nazionale sui flussi finanziari e di crescita coordinata di salari e profitti. L’egemonia keynesiana nelle due organizzazioni fu salda fin dalle origini, e la loro funzione stabilizzatrice nel corso dei “trenta gloriosi” è universalmente riconosciuta. Ma a seguito della crisi del ’73 e della svolta neoliberale il loro ruolo comincia ad essere percepito, specialmente negli Stati Uniti, come superfluo, se non fastidioso. Tant’è che tra i punti del programma elettorale che portò Reagan alla Casa Bianca figurava anche l’uscita degli USA dal FMI. Ma improvvisamente, una volta insediatosi, lo stesso Reagan operò un completo voltafaccia. Cosa era successo?
Con l’embargo petrolifero imposto dai Paesi arabi nel ’73, ed i prezzi del greggio alle stelle, le finanze degli Stati del Golfo persico erano state invase da una massa enorme di liquidità. I “petrodollari” così accumulati iniziarono ad affluire – non è ancor chiaro se spontaneamente o a seguito di pressioni non solo politiche – nelle casse delle grandi banche statunitensi. Tutto questo avveniva, come abbiamo visto, in un periodo di raffreddamento degli investimenti industriali in tutto l’Occidente, dovuto alle grandi conquiste ottenute dalle lotte del movimento operaio ed agli alti prezzi dell’energia. Allo stesso tempo, tuttavia, i governi dei Paesi da poco usciti dai processi di decolonizzazione avevano un disperato bisogno di liquidità, per rimettere in moto la produzione dopo anni di guerre devastatrici e di rapina delle risorse: le élites post-coloniali dovevano mantenere fede agli impegni presi con i propri popoli, che avevano sostenuto lo sforzo immenso delle lotte di liberazione. I grandi gruppi bancari trovarono quindi nei nuovi Stati una vasta platea di “clienti” per la massa monetaria che avevano accumulato. Anche perché, come sostenne Walter Wriston, allora alla testa di Citibank, “i governi non possono trasferirsi o scomparire”.
In questo panorama va inserita la giravolta da parte della presidenza Reagan. Lo shock monetarista imposto dal governatore della FED Paul Volcker, con un improvviso e massiccio aumento dei tassi di interesse, portò all’insolvibilità dei paesi del Terzo Mondo che avevano contratto i prestiti in dollari con le grandi banche. Fu a quel punto che si stipulò l’alleanza di ferro tra il tesoro USA, la BM e il FMI: furono promossi prestiti da parte delle istituzioni finanziarie di Bretton Woods, a patto che i Paesi indebitati varassero pacchetti di “riforme” in senso neo-liberista. Lo schema si è ripetuto da allora per il Messico ed il Cile (1982), per l’Argentina alla fine degli anni Ottanta, per la Russia e le “tigri asiatiche” ed ancora il Messico a metà anni Novanta, e di nuovo per l’Argentina sulla fine di quel decennio. E finalmente, questa volta con l’Unione Europea al posto del Tesoro USA a completare la Trojka con FMI e BM, per i paesi dell’Europa mediterranea a partire dalla crisi del 2008. Le eccedenze di capitale prodotte dalle varie crisi susseguitesi nell’ultimo trentennio hanno così trovato impieghi remunerativi a mano a mano che le ricette alla base delle “riforme” venivano varate, ricette al centro delle quali stanno immancabilmente programmi di privatizzazione degli asset strategici nazionali e delle assicurazioni sociali (su tutti, sanità e pensioni).
L’indebitamento delle famiglie ha costituito l’olio che ha lubrificato il motore della crescita, visto che le riforme ne hanno minato il potere d’acquisto e la capacità di risparmio. Il crollo del mercato immobiliare statunitense ha dimostrato che in base a questo meccanismo un equilibrio stabile non poteva essere mantenuto. Lo stesso principio vale, ancora, per la vecchia Europa. E non è certo una casualità che agli Stati sia stato reso impossibile l’indebitamento per una quota superiore al 60% del PIL, mentre ai privati sia lasciato un margine di indebitamento del 130%. Il debito privato è funzionale, almeno finché non produrrà l’esplosione di una nuova bolla finanziaria come successo negli Stati Uniti del 2008, a finanziare le esportazioni del mercantilismo tedesco. I ceti popolari e le classi medie disastrate dalla crisi a regime normale non potrebbero infatti supportarle a sufficienza. Mentre i conti pubblici vengono peggiorati dall’evasione fiscale delle oligarchie, che acquistano prodotti di lusso made in Germany invece di contribuire, con le tasse, al sostegno del welfare state.