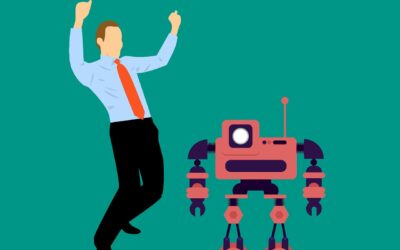Non c’è dubbio che oggi i vincoli di appartenenza del singolo alla comunità politica si siano indeboliti, che i legami di solidarietà siano venuti meno, che prevalgano logiche conflittuali, sentimenti di insicurezza, precarietà e frustrazione. La crisi della politica coincide nei ceti popolari con una percezione di abbandono da parte delle istituzioni e di esclusione dai meccanismi della rappresentanza. Gli Stati nazionali non riescono più né ad accogliere le domande insoddisfatte che vengono dal basso, né a includere i singoli individui nel “noi” più ampio della comunità. I motivi non possono essere sottovalutati. I governi rispondono sempre meno ai propri elettori perché la sovranità degli Stati è stata svuotata negli anni prima dalla globalizzazione neoliberale, poi dal cosiddetto pilota automatico messo in moto dalla tecnocrazia europea.
I movimenti comunemente definiti populisti prevalgono non tanto in virtù di ricette politiche concrete, quanto dalla loro capacità di ripoliticizzare il corpo sociale in uno spazio politico ormai impoverito e svuotato. La loro forza sta nel potere di un discorso che, in risposta alla perdita di sovranità, ricostruisce i legami collettivi e rinomina un patto sociale tra coloro che si sentono esclusi e abbandonati dalle élite.
Nel frattempo le forze maggioritarie di sinistra hanno dimostrato di non comprendere le distorsioni più vistose prodotte dalla globalizzazione, nell’illusione che questa avrebbe creato più opportunità per tutti. Hanno ignorato il crescere dell’incertezza, della paura e della solitudine nei ceti popolari. Hanno trascurato la domanda di protezione che proveniva dal basso. Anziché dare risposte ai bisogni, la sinistra ha finito per identificarsi nella parte del difensore d’ufficio dei mercati e della finanza globale, dello spread e delle compatibilità europee. La risposta che si attendeva è arrivata invece da tutt’altra direzione. E’ il populismo ad aver colto l’esigenza di protezione, il bisogno di ridefinire la sovranità degli Stati nazionali e ne ha fatto un’occasione per ricostruire nuovi legami d’identità collettiva: il “noi” di un popolo fluido ed espansivo contrapposto all’establishment in una nuova frattura antagonistica tra basso e alto.
Nel tema della sovranità il populismo trova una risorsa discorsiva efficace. Affermare di voler restituire agli elettori popolari il diritto di decidere del proprio destino senza subire i diktat del capitale finanziario significa dare risposte a chi non si sente rappresentato, a chi chiede protezione nel silenzio e nella solitudine. L’antagonismo con la finanza internazionale e la bandiera della sovranità popolare consentono oggi ai populismi di ripolarizzare lo spazio politico attorno a dicotomie secche e di ricostruire relazioni inclusive nei corpi sociali. Il mainstream dei media ha ridefinito questo fenomeno di ripoliticizzazione degli elettorati popolari con un termine carico di significati negativi – sovranismo – in origine coniato per indicare la politica protezionistica di Donald Trump, in seguito esteso ai sostenitori della sovranità nazionale degli Stati, da ultimo, utilizzato per le posizioni euroscettiche ed eurocritiche. Ma proprio attorno alla vicenda legata alla nuova presidenza degli Usa il mainstream ha mantenuto un atteggiamento superficiale e miope che ha impedito di comprenderne a fondo la novità. Trump si è imposto su Hilary Clinton perché ha saputo polarizzare lo spazio della contesa politica secondo la faglia dell’antagonismo tra popolo ed élite, relegando la sua avversaria nel ruolo di paladina dell’establishment. Una mossa che gli ha consentito di intercettare il voto degli operai e della classe media lavoratrice, vittima di vent’anni di deindustrializzazione. Trump è stato in grado di mobilitare l’elettorato ricorrendo anche a parole, simboli e rivendicazioni tipiche del repertorio della sinistra, facendo della difesa del diritto degli Stati a decidere i propri destini dall’ingerenza dell’economia globalizzata.
Certo, la critica dei populisti alle lobby, ai circoli finanziari e ai poteri tecnocratici tende alle volte a sfociare nell’ossessione e nel complottismo sgangherato. Ma non tutto di questa difesa della sovranità può essere ridotto a paranoia, a regressione. La domanda di “protezionismo” che torna ad affacciarsi nella politica, malgrado i tabù e i divieti, è in realtà il sintomo dell’indebolimento della sovranità popolare – un concetto cruciale nella storia del pensiero liberale e democratico, a partire dal Leviatano di Hobbes, passando per Locke e Rousseau, fino alle più recenti correnti della filosofia politica. La forza del populismo sta nella rivendicazione di uno spazio politico reale in cui la sovranità popolare possa esercitarsi: non una dimensione astratta e burocratica, come quella dei mercati finanziari e della tecnocrazia europea appunto, ma quella concreta (sebbene artificiale) del popolo e della nazione.
Anche perché nell’opinione pubblica è percezione sempre più diffusa che la volontà dell’elettorato conti sempre meno di fronte alle pressioni dell’Europa. Le politiche di austerity e di rigore disegnano una rete di vincoli, un ristrettissimo orizzonte di compatibilità che definiscono in ultima istanza ciò che i governi possono e non possono fare, con buona pace degli elettori.
La sovranità rappresenta, così, uno dei temi più sentiti nelle società europee e anche uno dei più delicati. A dispetto di chi professa il mantra del tramonto della sovranità. L’attuale scenario di post-sovranità, nella globalizzazione neoliberale, non ha certo significato mitigazione del potere, ma al contrario ha lasciato campo aperto ai poteri selvaggi transnazionali. Inoltre – come giustamente scrive Nello Preteorossi in Ciò che resta della democrazia (Bari, 2014) – essendosi “la democrazia impiantata nell’albero della sovranità, come sovranità popolare, combattere la sovranità politica ha significato, di fatto, indebolire la democrazia”.
E sa convincere assai poco l’idea di un passaggio indolore verso una politica senza sovranità, nella quale il cittadino cederebbe volentieri il passo al cosmopolita. L’idea che la crisi della sovranità sia un problema solo per gli Stati non è accettabile. Essa, infatti, è un problema anzitutto per le persone, perché senza sovranità i loro diritti politici e sociali non sono garantiti e le politiche redistributive non si possono attuare – come ci ricorda Massimo Luciani (Sovranità, Italianieuropei 7/2011). Pertanto la questione della sovranità continua, ancora oggi, a porsi, reclamando che si scelga tra il rilancio delle antiche sovranità nazionali (pur conservando le necessarie interdipendenze) e la costruzione di sovranità più ampie, magari continentali (ma manca quella spinta di energia politica e le condizioni politiche, sociali e culturali in grado di produrre un salto in quest’ultima direzione. Come ben sapeva Von Hayek, la via della sovranità europea porta inevitabilmente allo Stato minimo, date le radicate differenze di contesto fra i rispettivi popoli). Senza restare nel limbo nel quale oggi ci troviamo.
Sovranismo, come già ricordato, è il termine carico di significato negativo con il quale vengono squalificate e delegittimate le ragioni di chi evidenzia il nesso fra sovranità, popolo e nazione. Un nesso che ha un ruolo centrale nel «populismo». Ciò che l’antisovranismo delle establishment (di destra quanto di sinistra) fatica ad accettare è il fatto che la sovranità popolare quale si esprime nel suffragio universale — ambedue pietre angolari della democrazia — sia strettamente intrecciata alla sovranità nazionale. Intrecciata cioè – come ha giustamente ricordato Galli della Loggia nei suoi ultimi editoriali per il Corriere della sera – con uno spazio storico-culturale (quello rappresentato dalla nazione appunto) che, tranne rarissimi casi, s’identifica anche con uno spazio geografico. L’esistenza di questo legame inscindibile è testimoniata innanzi tutto dalla storia: non è mai esistito, infatti, nel mondo moderno, un regime democratico che non si sia affermato in uno spazio nazionale e rivendicando alla nazione-popolo la sovranità su di esso.
Democrazia e Stato-nazione possono essere in un qualche modo sovrapposti. La spinta all’autogoverno non può nascere tra individui sparpagliati, che semplicemente «si conoscono». Può sorgere solo all’interno di una “data” comunità (in quanto esito, sempre aperto e provvisorio, di un “accumulo di artificialità”), di un demos per l’appunto, che si riconosca preliminarmente come tale. Cioè come un insieme di persone le quali – consapevoli di condividere un territorio, una storia, dei costumi, dei valori, e del legame che tale condivisione crea – decidono di volersi rendere padroni del proprio destino. Essendo poi in grado di mettere concretamente in pratica un tale autogoverno attraverso un medium comunicativo adeguato, disponendo cioè di quello strumento imprescindibile rappresentato da un comune linguaggio. Nazione significa precisamente tutte queste premesse dell’autogoverno democratico: un «noi» che ci fa cosa diversa dagli «altri», senza naturalmente che ciò che è altro da noi diventi perciò stesso un nemico.
La democrazia ha quindi bisogno di una spazio, di un contesto concreto cui riferirsi (l’autodeterminazione democratica – per dirla con Habermas – non può esistere senza una dialettica dentro/fuori), e finora lo schema dello Stato-nazione dalla natura democratico-costituzionale e sociale che l’Europa ha conosciuto nel secondo dopo guerra è stato il terreno ideale entro cui imporre il primato della dimensione politica sulla dimensione economica ed esercitare il conflitto sociale in senso favorevole alle classi lavoratrici.
Naturalmente la critica ai processi di superamento degli Stati nazionali può degenerare in un sentimento statolatrico o nella teoria della “naturalità” delle nazioni, ma non è affatto necessariamente legata a questi presupposti. In una prospettiva più matura e progressiva, prevale la convinzione che non possa darsi società degli uomini senza un vincolo autenticamente politico e che un simile vincolo politico non possa darsi, a sua volta, senza ragioni materiali e ideali del vivere assieme. Questo minimum hanno saputo crearlo gli Stati nazionali, garantendo quel senso minimale di identificazione e di missione comune, ma non sembra che sia in grado di crearlo il loro cosmopolitico superamento.
A proposito di idea di nazione, ha avuto notevole fortuna la distinzione fra una nozione civico-territoriale (modello francese) e una nozione etnica (modello tedesco). La prima privilegerebbe, al di là delle radici etniche, il senso di una comunità civica e il sentimento di lealtà repubblicana. La seconda enfatizzerebbe invece la continuità popolare, esprimerebbe una comunità di storia e di destino. La traduzione di queste due concezioni sarebbe evidente nelle differenti legislazioni sulla cittadinanza giuridica: la prima ispirata allo ius soli, la seconda alla ius sanguinis. Quel che è certo è che la nazione non si realizza una volta per tutte, ma ha bisogno di una riaffermazione ricorrente nel tempo. A ben vedere anche la distinzione fra i due modelli sfuma e sembra convergere se consideriamo che anche la nazione civico-territoriale ha bisogno di un’identità culturale, di una religione civile, che esprima la cittadinanza attraverso miti e memorie comuni; d’altra parte, la nazione etnica deve passare attraverso processi di territorializzazione e di politicizzazione. Ne consegue che nella vita politica moderna è possibile la presenza simultanea di due (o più) livelli di inclusione e mobilitazione che, entrambi, possono essere legittimamente chiamati nazionali, anche se in un caso la base è etnica, e nell’altro politico-territoriale.
In ogni caso, non è affatto vero che ogni forma di appartenenza sia «nazionalista». Ma, a parte il fatto che l’identificazione tra nazione e nazionalismo è storicamente falsa (la nazione, anzi più propriamente lo Stato-nazione, è soprattutto un contenitore, un contesto, che definisce uno spazio e un terreno comune per l’esercizio della sovranità popolare), è il punto teorico-politico a essere fuorviante. I bisogni di appartenenza e identità sono profondi e radicati e possono essere declinati in molti modi, anche democratici e aperti – come scrive Nello Preterossi in un suo recente saggio (Radicalità, in “Filosofia politica”, aprile 2017). Soprattutto, le forme politiche che l’Occidente ha inventato sono ridotte: città, imperi, Stati. La forma impolitica ancora non è stata inventata. Credere che, come per incanto, lo spazio liscio globale non generi refrattarietà identitarie e caos geopolitico (vedi il caso Catalogna), è molto ingenuo, e in fondo funzionale alla narrazione globalista neoliberale.
Quel che è certo, comunque, è che la necessità di legami prepolitici e di comunità per il buon funzionamento di una democrazia rappresenta il punto forse più trascurato nella cultura della sinistra. Eppure, come ha sostenuto R. Dahrendorf (Quadrare il cerchio, Laterza, 1995) il sentimento di coesione e di lealtà politica fra i cittadini è una variabile essenziale di un sistema democratico. E la coesione e la lealtà politica – per quanto astrattamente garantite nelle società moderne dallo strumento del diritto – suppongono comunque l’esistenza di legami prepolitici fra i membri del gruppo, rinviano ad una identità collettiva, come giustamente afferma Danilo Zolo in un suo prezioso e imprescindibile libro di diversi anni fa (I signori della pace. Una critica del globalismo giuridico, Carocci, 2001). Ed è provato che la tenuta dei legami identitari si fa sempre più incerta via via che l’ambito geopolitico di uno Stato si dilata fino a includere culture molto diverse fra loro (R. Dahl, in Sulla democrazia, Laterza, 2002, pone il dato di un limitato pluralismo subculturale fra le condizioni favorevoli alla democrazia). Neppure il più astratto “patriottismo dei diritti” può fare a meno, per così dire, di una qualche “intimità” fra i membri del gruppo (Böckenförde, grande giurista tedesco di fede socialdemocratica, utilizza a tal proposito il concetto di “omogeneità relativa”): essi non possono essere dei soggetti “estranei” gli uni agli altri. L’estraneità è l’opposto della solidarietà democratica. La prova a contrario viene oggi fornita – e prendo qui in prestito le parole dello stesso Zolo – dagli estesi fenomeni di insofferenza e di razzismo che colpiscono le società “multiculturali” e che la mediazione formale del diritto non riesce né a prevenire né a reprimere. Insomma, l’identificazione con una qualche comunità concreta di appartenenza costituisce una risorsa necessaria al buon funzionamento di una democrazia. Se manca un sostrato “oggettivo”, se manca il radicamento in una forma di vita, le comunità politiche non hanno alcuna possibilità di costituirsi e di rimanere vitali.
Diversamente dall’universalismo liberale, l’universalismo democratico è radicato in e si riferisce a uno specifico demos costituito da persone che sono unite da qualcosa di più dell’umanità e della ragione. La solidarietà civica è radicata nelle identità collettive particolari (che non hanno certo un fondamento essenzialista o assoluto, perché appartengono alla dimensione storico-culturale che come tale ha natura transeunte e relativa); la solidarietà cosmopolitica si sostiene unicamente in virtù dell’universalismo morale dei diritti umani. Questo implica il riconoscimento che la cittadinanza democratica è una politica di identità che non può essere così astratta e senza fondamenti come lo è l’appartenenza all’umanità. D’altro canto, tuttavia, la cittadinanza democratica – come ha ben spiegato Nadia Urbinati in un suo lavoro del 2004 (Ai confini della democrazia, Donzelli) – è una identità politica che educa i cittadini a vedere gli altri come uguali, e questo è ciò che rende la politica democratica un giuoco aperto all’auto-revisione e, soprattutto, le questioni relative ai confini dello Stato questioni sempre soggette ad aggiustamenti, nel tentativo di rendere il governo dei flussi migratori il più possibile coerente con i principi di umanità e giustizia e le politiche di integrazione degli immigrati il più possibile coerenti con i principi democratico-costituzionali.
La questione, una volta di più, è quella – cruciale – dei processi di integrazione politica e sociale. Cosa ci fa stare assieme? Come questo stare assieme può essere realizzato? Quali sono i processi che determinano il senso di appartenenza a una comunità politica? Nella modernità la nazione ha compensato il vuoto lasciato dalla religione con l’avvento della secolarizzazione (la democrazia, va ricordato, nasce e si sviluppa nel mondo moderno come democrazia “nazionale”). A svolgere quella funzione di unificazione politica sono intervenute nel Novecento i partiti e le identità politiche di massa e anche, in un certo senso, il Welfare State. Dopo l’eclisse della nazione (almeno in Europa) e la crisi delle appartenenze politico-ideologiche, cosa occupa oggi quel vuoto simbolico che caratterizza gli ordinamenti secolari?
Come strumento di mobilitazione e unificazione politica c’è la tensione verso una società altra a cui allude la nostra Costituzione (quasi un recupero del nesso politico/simbolico: se ogni Costituzione democratica è un potente strumento di integrazione politica e di cambiamento sociale, non può fare a meno – citando Habermas – del senso di ciò che manca e perciò è ancora possibile), ma si tratta di un’opzione svuotata in parte di significato e di prospettiva concreta nell’ambito dell’attuale architettura Ue.
Concludendo, il populismo rappresenta una reazione ai processi di svuotamento della sovranità democratica dall’alto e di sradicamento sociale in basso ai quali abbiamo assistito negli ultimi decenni. Una reazione che ha il grande merito di affrontare i nodi e le contraddizioni principali, che sono il tema del recupero della sovranità democratica per restituire senso alle promesse di trasformazione sociale iscritte nella Costituzione repubblicana (oltre che per rilanciare su nuove basi un processo diverso di cooperazione e solidarietà fra i paesi europei) e la ridefinizione delle forme del legame sociale.
Recupero della sovranità democratica significa innanzitutto rideclinare il nesso nazionale/sovranazionale, rivedendo criticamente la posizione dell’Italia all’interno dell’Ue con tutto ciò che ne consegue in termini di sapiente messa in discussione degli attuali vincoli europei, a favore di un modello di internazionalismo “equilibrato” che restituisca agli Stati la capacità di governare e orientare i processi economici. Pur nella consapevolezza che le democrazie nazionali devono oggi confrontarsi con problemi che sfuggono in parte alla loro capacità di controllo e gestione: del governo dei processi migratori ai flussi della comunicazione globale, dai problemi di approvvigionamento energetico agli effetti prodotti dalla guerra e dal terrorismo, e via discorrendo. Resta poi la difficoltà di affrontare in un’ottica puramente “domestica” quei grandi processi che potrebbero minacciare la stessa sopravvivenza della specie: dall’impatto delle attività umane sull’ambiente e sul clima alle conseguenze non previste e potenzialmente disastrose degli sviluppi scientifico-tecnologici, per loro natura globali e non iscrivibili dentro quadri di regolazione nazionale.